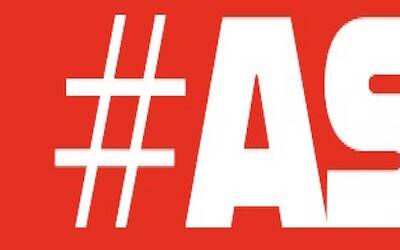Piadina Romagnola: Origini, Tradizione e Differenze con la Versione Riminese

Indicazione geografica protetta: la tutela della piadina romagnola
La piadina romagnola gode di una protezione ufficiale a livello europeo grazie al riconoscimento come Indicazione Geografica Protetta (IGP). Questa tutela conferisce al prodotto un marchio distintivo che ne garantisce origine e qualità, circoscrivendo la produzione esclusivamente alle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e alla parte orientale della provincia di Bologna oltre il fiume Sillaro. Solo in queste aree la piadina può essere fabbricata con le caratteristiche tradizionali che ne identificano l’autentica ricetta, assicurando così la salvaguardia di un patrimonio culinario radicato nel territorio.
Il simbolo che accompagna la piadina IGP rappresenta un gallo stilizzato affiancato da una spiga di grano, un marchio che certifica non solo la provenienza geografica ma anche la conformità del prodotto agli standard definiti dal disciplinare europeo. Tale regolamentazione ha lo scopo di valorizzare una specialità gastronomica che, pur diffusa in diverse varianti locali, mantiene una precisa identità legata alla Romagna. Il riconoscimento IGP non soltanto tutela i consumatori da imitazioni o produzioni non conformi, ma promuove anche la valorizzazione economica e culturale della zona di origine.
Differenze tra la piadina romagnola e quella riminese
La piadina romagnola presenta variazioni significative nel formato e nella consistenza a seconda della zona di produzione, con la distinzione principale che coinvolge la Romagna settentrionale e la fascia costiera riminese. Nelle aree a nord di Rimini, la piadina si caratterizza per un diametro contenuto tra i 15 e i 20 centimetri, con uno spessore medio di circa 8 millimetri. Questa versione appare più compatta e leggermente più rigida, rispondendo a esigenze storiche e di conservazione diverse rispetto alla variante riminese.
Al contrario, la piadina riminese si distingue per dimensioni più generose, generalmente comprese tra i 25 e i 30 centimetri di diametro, con uno spessore ridotto a circa 3 millimetri. La sua struttura sottile conferisce maggiore morbidezza e flessibilità, caratteristiche che ne hanno favorito la diffusione soprattutto nelle località costiere. Questo tipo di piadina si presta a un’ampia varietà di farciture, influenzando così il modo in cui viene consumata nei territori di produzione.
Inoltre, è importante sottolineare l’esistenza di prodotti affini, come il crescione o cassone, piatto molto simile alla piadina ma farcito e chiuso a mezzaluna, il quale condivide con la piadina un’origine e una storia gastronomica comune. Queste differenziazioni morfologiche e di consistenza riflettono una tradizione artigianale fortemente legata alle specificità culturali e geografiche della Romagna, che il disciplinare IGP intende tutelare e valorizzare.
La storia e le origini antiche della piadina
Le radici storiche della piadina affondano in epoche antichissime, con innesti culturali che risalgono addirittura all’antichità etrusca e romana. Studi gastronomici hanno evidenziato un legame tra la piadina e le antiche farine azime, tipiche dell’area etrusca, che venivano cotte su teglie di terracotta, precursori del moderno “testo”. Questa tradizione ha attraversato i secoli, giungendo fino a noi con una tecnica di preparazione sostanzialmente invariata: un impasto semplice, privo di lievito, cotto direttamente sulla brace.


È significativo notare come Virgilio, nell’Eneide, descrivesse un pane sottile, arrostito sotto la cenere e spezzato in ampi pezzetti, una testimonianza letteraria che sottolinea quanto questo tipo di preparazione fosse già radicato nella cultura romana. L’etimologia stessa della parola “piada” sembrerebbe derivare dal greco antico plàthanon, termine che indica la teglia sulla quale veniva cotto l’impasto, un dettaglio che riflette probabilmente l’influenza bizantina, in Romagna fino all’VIII secolo. Questi elementi avvalorano la teoria di una diffusione organica e pluristratificata nel tempo del cibo popolare romagnolo.
Durante il Medioevo, nei momenti di crisi come la devastante peste nera, i pani azimi, antenati della piadina, ripresero predominanza rispetto al pane lievitato, meno accessibile. Documenti storici, come la “Descriptio Provinciae Romandiolae” del cardinale Anglico de Grimoard del 1371, testimoniano l’importanza sociale della piadina, che veniva prodotta con farine semplici, acqua, sale e talvolta latte o strutto. Inoltre, in alcune zone come Modigliana, era prevista una tassazione specifica basata sul consumo di piade, segno della diffusione capillare di questo alimento tra le popolazioni rurali.
La penisola ha visto trasformazioni profonde nella composizione stessa della piadina, che per secoli è stata il cibo della gente più povera. La sostituzione o integrazione della farina di grano con farine di castagne, ghiande o mais testimoniano l’adattabilità del piatto alle disponibilità agricole e alle necessità economiche delle comunità romagnole. Accorgimenti come l’impasto con acqua di cottura del cotechino o l’uso di ciccioli al posto dello strutto dimostrano una ricerca costante di miglioramento del sapore senza rinunciare all’economico e al pratico.
Infine, la piadina conquistò la sua definitiva consacrazione culturale e gastronomica all’inizio del Novecento anche grazie a Giovanni Pascoli, che le dedicò un poema celebrativo. Nel componimento La Piada, Pascoli ne riconosce il valore identitario e popolare, descrivendone le fasi di preparazione come un gesto quotidiano e familiare, in cui la semplicità delle materie prime si accompagna a un forte legame emotivo con la tradizione romagnola. Questa narrazione poetica ha contribuito a elevare la piadina da semplice alimento povero a simbolo del patrimonio culturale della Romagna.
DIRETTORE EDITORIALE
Michele Ficara Manganelli ✿
PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI
Per acquistare pubblicità CLICCA QUI
Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI