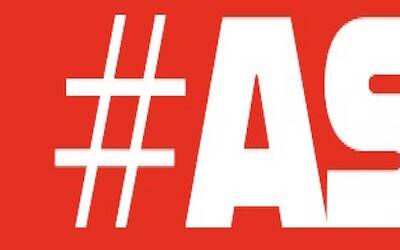Paesi UE avanzano sul bilancio pluriennale mentre il Parlamento è bloccato da tensioni politiche e divergenze.

Proposta di bilancio a lungo termine dell’UE
In un contesto di crescente tensione e competizione tra i vari Stati membri, la proposta di bilancio a lungo termine dell’Unione Europea per il periodo 2028-2034 sta prendendo forma. Secondo un documento di lavoro recentemente acquisito da Euractiv, mentre il Parlamento è coinvolto in una serie di conflitti interni, le capitali europee stanno avanzando in linea con il quadro presentato dalla Commissione. Questo approccio mira a semplificare e rendere più efficiente la struttura del bilancio, un obiettivo che appare sempre più necessario in un’Unione che deve affrontare sfide economiche e sociali complesse.
Il documento abbozza l’intenzione di consolidare quattro nuove voci di bilancio e di accorpare i sussidi per l’agricoltura e per le regioni in piani nazionali che saranno negoziati tra le capitali dell’Unione e Bruxelles. Se il progetto dovesse rimanere invariato, rifletterebbe un’ampia approvazione dell’approccio presentato dalla Commissione. Inoltre, il testo distingue le parti più controverse del nuovo megafondo industriale da 234 miliardi di euro, dai programmi di competitività e da questioni orizzontali di bilancio, che saranno oggetto di discussione da parte dei ministri per gli affari europei (GAC) martedì prossimo.
Il resto delle tematiche critiche sarà affrontato in una futura riunione GAC il 17 novembre, dove ci si aspetta una discussione accesa riguardo ai piano nazionali proposti, significativi per la strategia di bilancio a lungo termine dell’Unione. Si tratta di un passaggio cruciale che potrebbe definire come le risorse dell’UE saranno allocate nei prossimi anni, influenzando direttamente gli Stati membri e le loro politiche interne.
Controversie nel Parlamento europeo
Il Parlamento europeo si trova attualmente in un mare di conflitti interni, in particolare riguardo alla proposta di bilancio a lungo termine proposta dalla Commissione. Ciò ha portato ad una crescente frustrazione tra i membri dell’assemblea, i quali si oppongono all’idea di unire i sussidi per l’agricoltura e per le regioni in un unico piano nazionale. La presentazione di questi piani dall’alto, percepita come una minaccia alla sovranità degli Stati membri, ha esacerbato le tensioni tra le diverse fazioni politiche.
La principale contestazione si concentra sulla gestione e distribuzione dei fondi. Mentre alcuni gruppi politici propugnano che la fusione dei fondi garantirebbe maggiore efficienza e una distribuzione più equa, altri temono che ciò possa portare a una riduzione degli aiuti per le regioni più bisognose. Un aspetto cruciale della disputa riguarda la tipologia di progetti finanziabili e se debbano essere imposti criteri di selezione basati solo sul merito o se sia necessario garantire una “bilanciatura geografica” per favorire i paesi meno sviluppati.
Inoltre, la polemica si alimenta con l’introduzione del nuovo fondo industriale da 234 miliardi di euro, che suscita preoccupazioni tra i membri dell’UE che vedono in questo un rischio di concentrazione dei fondi nelle mani dei paesi più ricchi. Il dibattito attorno a queste questioni presenta una difficoltà intrinseca, poiché i paesi più abbienti come Francia e Germania difendono l’idea di un accesso a tali fondi basato esclusivamente sulle prestazioni economiche, contro le esigenze di equità espresse dai paesi più piccoli e vulnerabili. Questa divisione potrebbe influenzare anche la futura agenda politica dell’Unione e la sua capacità di affrontare crisi comuni.
La posizione degli stati membri
Le svariate posizioni degli Stati membri riguardo alla proposta di bilancio dell’Unione Europea evidenziano significative disparità tra le nazioni più ricche e quelle meno sviluppate. La tensione si manifesta principalmente attorno alla gestione dei fondi, soprattutto nella pianificazione del nuovo fondo industriale da 234 miliardi di euro e nei programmi di competitività, con il programma Horizon Europe da 175 miliardi di euro che gioca un ruolo cruciale. I paesi più agiati, tra cui Francia e Germania, sostengono che l’assegnazione alle iniziative debba basarsi esclusivamente sul merito, il che prefigura una competizione accesa e, potenzialmente, un esito sfavorevole per i progetti delle nazioni più povere.
Al contrario, le nazioni più piccole, come quelle dell’Europa dell’Est e del Sud, spingono per una “bilanciatura geografica”. Questo concetto implica l’assegnazione di fondi in modo da garantire che gli aiuti raggiungano anche le regioni e i paesi meno favoriti, rispondendo a esigenze strutturali e storiche di sviluppo. La richiesta di queste nazioni incontra però una certa resistenza da parte delle economie più forti, che richiedono una revisione profonda dei criteri di accesso.
Inoltre, la discussione sul fatto se il nuovo fondo debba o meno permettere aiuti di Stato, generalmente vietati dalle normative europee, si affianca al dibattito principale. La proposta indica che in casi “eccezionali e debitamente giustificati” potrebbe esserci flessibilità in tal senso, un punto che genera preoccupazioni sulla potenziale creazione di disparità tra gli Stati membri in termini di sostegno economico. La volontà di procedere in modo rapido, attesa dai Paesi, sembra controbilanciata dalla necessità di trovare un consenso che rimanga equo e sostenibile per l’intero blocco europeo.
Fondo industriale e programmi di competitività
Il nuovo fondo industriale da 234 miliardi di euro, atteso con impazienza per il suo potenziale impatto sull’industria europea, si trova al centro di un acceso dibattito. Questo strumento è concepito per stimolare la competitività, ma solleva interrogativi significativi tra gli Stati membri riguardo i criteri di accesso. Le nazioni più abbienti, come Francia e Germania, sostengono che il supporto dovrebbe essere assegnato esclusivamente in base al merito dei progetti, un approccio che potrebbe iniziare una competizione sfavorevole per i progetti delle nazioni meno sviluppate. D’altra parte, i paesi meno ricchi evidenziano la necessità di una “bilanciatura geografica”, sostenendo che il finanziamento dovrebbe garantire una distribuzione equa dei fondi per affrontare le storiche disparità economiche e sociali.
Un ulteriore punto di controversia riguarda il programma Horizon Europe da 175 miliardi di euro, le cui iniziative dipenderanno dalla stessa logica di assegnazione dei fondi. I rappresentanti delle economie più solide, temendo una dispersione delle risorse, chiedono chiarimenti su come l’Unione possa garantire il finanziamento solo a progetti che dimostrino un valore aggiunto concreto. La proposta di adattare i criteri per i paesi meno avvantaggiati si scontra con l’idea dei “progetti altamente competitivi”, lasciando i membri dell’UE in una situazione di stallo, mentre i ritardi normativi si accumulano.
La questione di includere aiuti di Stato nel nuovo fondo, normalmente contro le norme europee, introduce un ulteriore livello di complessità. Il documento di proposta prevede che in casi “eccezionali e debitamente giustificati”, possa esserci spazio per tali aiuti, generando preoccupazioni tra i membri dell’Unione sulla potenziale creazione di disparità. La necessità di trovare un equilibrio tra flessibilità e equità è ora più urgente che mai, poiché i lavori volti a indirizzare le risorse economiche dell’Unione devono proseguire senza interruzioni, pur scontrandosi con l’inevitabile resistenza da parte dei paesi più ricchi.
Prossimi passi e scadenze
La struttura della procedura di approvazione della proposta di bilancio a lungo termine dell’Unione Europea presenta delle scadenze cruciali che potrebbero determinare la direzione futura delle politiche economiche del blocco. Con l’obiettivo di definire un pacchetto negoziale completo per il Consiglio Europeo entro il 18-19 dicembre, la presidenza danese sta esercitando pressioni per una rapida conclusione dei lavori. Questo approccio è visto come fondamentale per garantire un accordo sull’importante bilancio entro la fine del 2026, un orizzonte temporale che gli Stati membri considerano sempre più urgente.
Le prossime discussioni si incentreranno sulla risoluzione delle controversie relative ai piani nazionali e sull’inclusione di aspetti delicati come l’assistenza agli Stati in difficoltà economica. Data la complessità delle posizioni divergenti, si prevede che la riunione GAC del 17 novembre rappresenterà un punto critico per il futuro dell’integrazione europea. In questo contesto, le trattative sul piano nazionale, che potrebbero rivelarsi motivo di frizione tra le nazioni più ricche e quelle in via di sviluppo, saranno messe alla prova, poiché le aspettative di un accordo devono confrontarsi con le realtà storiche e socio-economiche dei diversi Stati.
La discussione si articolerà attorno al bilancio complessivo e all’allocazione dei fondi, affiancata dalla deliberazione su come adattare i requisiti alle circostanze particolari dei membri dell’UE. Dalle dichiarazioni preliminari, è evidente che ciascuna nazione avrà un ruolo decisivo nel determinare le espressioni di sostegno economico e di crescita. Questa fase di negoziato culminerà in dicembre e porrà le basi per l’attuazione di programmi che potrebbero ridefinire il panorama economico dell’Unione per il prossimo decennio.
DIRETTORE EDITORIALE
Michele Ficara Manganelli ✿
PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI
Per acquistare pubblicità CLICCA QUI
Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI