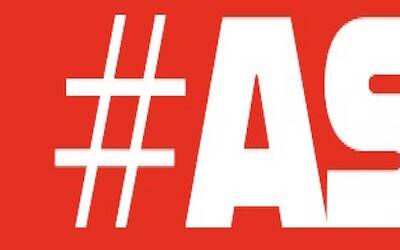ESMA fornisce linee guida essenziali per prevenire il greenwashing e garantire trasparenza ai consumatori

Cosa fare per evitare il greenwashing
Nel contesto dell’accresciuta attenzione globale verso la sostenibilità, è essenziale che le aziende adottino un approccio rigoroso per evitare il greenwashing, mantenendo la fiducia degli investitori e del pubblico. Per contrastare questa pratica ingannevole, le aziende devono seguire linee guida chiare e pratiche consolidate. È fondamentale evitare espressioni ambigue, come “sostenibile” senza fornire dettagli sul contesto o sull’impatto reale derivante. Questa mancanza di chiarezza può generare aspettative non corrispondenti alla realtà dei fatti. È altrettanto importante non adottare la strategia del cherry-picking, che consiste nel presentare solo i dati più favorevoli riguardo alle pratiche ESG, trascurando informazioni meno positive. Tale approccio non solo distorce la verità, ma può anche esporre l’azienda a rischi reputazionali significativi.
Le aziende devono, quindi, fornire dati comparabili e verificabili, presentando informazioni che seguano criteri di omogeneità (like with like). Questo significa che qualsiasi comparazione deve essere basata su soglie e parametri rigorosamente definiti, attraverso fonti chiaramente documentate. Inoltre, le immagini e il linguaggio utilizzati nella comunicazione devono riflettere in modo coerente il profilo ESG effettivamente raggiunto dall’azienda. L’adozione di questi principi non solo aiuta a evitare il greenwashing, ma promuove anche una maggiore trasparenza, rendendo più semplice per gli investitori e i consumatori prendere decisioni informate. La chiave per il successo risiede nella comunicazione onesta e nella prassi operativa trasparente, in modo da costruire un rapporto basato sulla fiducia e sulla responsabilità.
I quattro principi fondamentali
Per prevenire il greenwashing e garantire dichiarazioni autentiche in ambito sostenibilità, è cruciale che le società finanziarie aderiscano a quattro principi cardine delineati dall’ESMA. Questi principi non solo stabiliscono standard elevati per le comunicazioni, ma mirano anche a consolidare la fiducia tra gli investitori e le entità finanziarie. In primo luogo, la accuratezza delle affermazioni deve essere rigorosamente rispettata; ogni dichiarazione deve essere precisa, senza ambiguità o omissioni significative che possano indurre in errore. La mancanza di chiarezza rischia di compromettere la credibilità delle istituzioni finanziarie.
Un secondo principio è l’accessibilità delle informazioni, che implica che i contenuti devono essere comprensibili per una vasta gamma di interlocutori, inclusi gli investitori retail. Questo richiede la creazione di materiali informativi che non solo siano facili da interpretare, ma che consentano anche un approfondimento graduale delle tematiche ESG. La trasparenza della comunicazione è fondamentale per evitare malintesi e rafforzare la fiducia.
Inoltre, il principio di sostegno documentale sottolinea l’importanza di basare ogni affermazione su dati concreti, metodologie verificate e confronto con benchmark rilevanti. Ogni claim deve essere supportato da prove chiare, per garantire che le dichiarazioni siano fondamentalmente reali e verificabili. Infine, il principio di aggiornamento richiede che le informazioni siano sempre aggiornate, riportando date e contesti chiari per evitare che dati obsoleti possano ingannare gli investitori. In questo modo, le istituzioni finanziarie possono non solo tutelare la loro reputazione, ma anche contribuire in modo significativo a un mercato più equo e responsabile.
L’importanza delle etichette e certificazioni ESG
Nel panorama attuale delle comunicazioni di prodotto, l’uso di etichette e certificazioni ESG gioca un ruolo cruciale per le aziende che desiderano posizionarsi come sostenibili. Tuttavia, la proliferazione di questi indicatori richiede un’attenta contestualizzazione, per evitare che risultino abusati o fraintesi. L’ESMA sottolinea l’importanza di fornire chiarezza sull’interpretazione di tali riferimenti, affermando che è essenziale che il significato di qualsiasi etichetta o certificazione sia ben specificato agli investitori e al pubblico. A tal fine, è necessario spiegare in modo trasparente il valore reale di qualsiasi punteggio o classificazione ottenuta, che può variare non solo per le performance intrinseche, ma anche in relazione ai concorrenti o a gruppi comparabili di aziende.


In questo contesto, è fondamentale considerare che le etichette e i premi non devono essere presentati come garanzie assolute, ma piuttosto come parte di un insieme più complesso di informazioni. Le aziende devono chiarire se i loro punteggi ESG siano attribuiti in termini assoluti o relative a specifiche misurazioni di settore. Ad esempio, un prodotto che riceve un punteggio alto in un valore ESG potrebbe apparire favorabile, ma è cruciale fornire contestualizzazione rispetto ai concorrenti per evitare interpretazioni fuorvianti.
Oltre a ciò, è importante che le comunicazioni riguardanti le etichette e le certificazioni siano coerenti con le reali pratiche ambientali dell’azienda. In caso contrario, si rischia di alimentare una narrazione di greenwashing che può allontanare gli investitori e danneggiare la reputazione aziendale. Pertanto, una gestione oculata delle informazioni relative a etichette e certificazioni ESG deve includere un’analisi critica e una comunicazione efficace, assicurando che i messaggi siano non solo d’impatto, ma anche veritieri e rappresentativi delle reali attività sostenibili dell’azienda.
Esempi di buone e cattive pratiche
Nel contesto della comunicazione aziendale sulle pratiche sostenibili, è cruciale distinguere tra esempi virtuosi e comportamenti da evitare, per garantire una reale trasparenza e fiducia. Le buone pratiche comprendono la specificazione chiara di termini come “sostenibile”, accompagnata da informazioni dettagliate su come un’azienda stia effettivamente contribuendo a obiettivi ambientali. Ad esempio, invece di limitarsi a dichiarare di essere “sostenibili”, le aziende dovrebbero fornire dati quantitativi sul loro impatto ambientale, come le riduzioni delle emissioni di CO2 ottenute attraverso interventi specifici. Inoltre, è fondamentale presentare i dati in modo omogeneo, facilitando confronti utili che permettano agli investitori di capire la reale posizione dell’azienda nel panorama di sostenibilità.
D’altro canto, le cattive pratiche da evitare includono frasi vaghe e poco chiare. Definizioni generali e non specifiche, come “il nostro prodotto è migliore per l’ambiente”, possono alludere a impegni sostenibili senza nessuna prova reale. Altrettanto problematico è il cherry-picking, in cui le aziende mostrano solo i dati positivi riguardo alle loro performance ESG, escludendo informazioni che potrebbero presentare una realtà diversa. Questo approccio non solo mina la credibilità, ma può anche generare delusione e perdita di fiducia tra investitori e consumatori.
È inoltre essenziale che le comunicazioni siano accompagnate da immagini e contenuti coesi. Qualora un’azienda utilizzi immagini naturali o ideali senza un corrispettivo nella sua reale operatività, rischia di essere percepita come disonesta. Pertanto, la coerenza tra l’immagine aziendale e le pratiche operative è cruciale per evitare fraintendimenti e per instaurare relazioni fondate su un’onestà genuina. L’approccio consigliato implica una comunicazione chiara e lineare, con dettagli che sostengano ogni affermazione e un rispetto rigoroso dei principi di trasparenza e responsabilità. Solo così le aziende possono realmente posizionarsi come leader nel campo della sostenibilità, garantendo una reputazione stabile e orientata verso il futuro.
Il ruolo delle autorità di vigilanza
Il monitoraggio del rispetto delle normative che garantiscono la trasparenza nelle dichiarazioni sulla sostenibilità è una responsabilità cruciale delle autorità nazionali competenti (NCAs), supportate da organismi come l’ESMA, l’EBA e l’EIOPA. Queste autorità non solo devono intensificare la loro attività di vigilanza, ma anche promuovere azioni coordinate per combattere efficacemente il fenomeno del greenwashing. Attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati (SupTech), le NCAs saranno in grado di identificare in modo più tempestivo e preciso i comportamenti scorretti nel mercato finanziario e nei prodotti ESG. L’implementazione di tali strumenti permette una verifica sistematica delle affermazioni di sostenibilità fatte dalle aziende, contribuendo a mantenere elevati standard di integrità.
In questo contesto, è necessario sottolineare che l’autorità di vigilanza deve farsi carico di formare adeguatamente il personale attraverso un’istruzione specialistica, mirata a sviluppare competenze specifiche per identificare i casi di greenwashing e la loro sfumatura. In particolare, la formazione permetterà di rafforzare la comprensione delle metodologie utilizzate dalle aziende per valutare le proprie performance ESG e dei criteri utilizzati per certe certificazioni. Ciò garantirà che le autorità possano operare non solo come enti di controllo, ma anche come guide e riferimenti autorevoli per gli investitori, migliorando la qualità complessiva delle comunicazioni di marketing e promuovendo prassi aziendali etiche.
In aggiunta, l’ambito di intervento delle autorità include l’allineamento con regolamenti esistenti, come MiFID II, UCITS, PRIIPs, SFDR e il Regolamento sui Benchmark climatici. Questi strumenti già richiedono alle entità finanziarie di fornire informazioni che siano “eque, chiare e non ingannevoli”. Tali requisiti rappresentano un solido fondamento per ulteriori iniziative volte a rendere il mercato più chiaro e responsabile. Inoltre, le pratiche commerciali sleali, come disciplinate dalla Direttiva UCPD, impongono regole severe sulla veridicità delle affermazioni ambientali. L’implementazione efficace di queste normative, unita a una vigilanza attenta, avrà un impatto positivo non solo sulla fiducia degli investitori, ma anche sulla stabilità a lungo termine del mercato finanziario.
DIRETTORE EDITORIALE
Michele Ficara Manganelli ✿
PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI
Per acquistare pubblicità CLICCA QUI
Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI